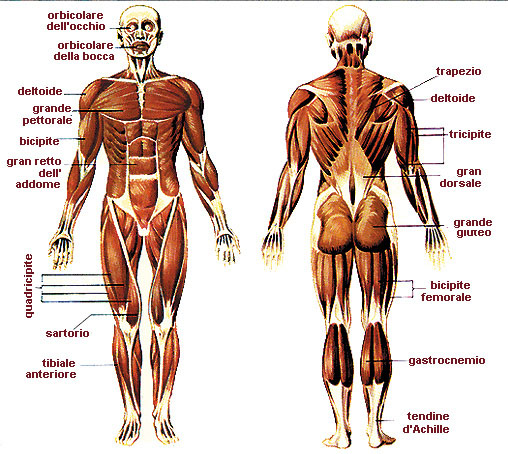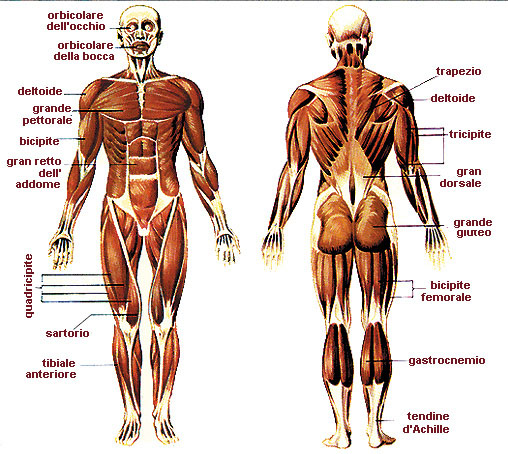Tessuto corporeo fondamentale dotato della proprietà contrattile, che
rende possibile il movimento di un corpo animale o di sue parti. ● Anat. -
La struttura del
m. è costituita dal tessuto muscolare
(V. MUSCOLARE), da vasi sanguigni e linfatici, da
fibre nervose di tipo motorio (le
piastre neuromuscolari, suddivise nelle
singole fibre muscolari e terminanti con una
placca motrice). Ogni
m. è mantenuto nella propria sede da una membrana elastica,
l'
aponeurosi. La distinzione dei
m. in volontari e involontari si
basa sulla loro azione fisiologica, mentre, rispetto al tipo di tessuto
muscolare di cui sono composti, essi possono essere suddivisi in striati e
lisci. Un'altra classificazione, in base alla forma, prevede
m. lunghi,
brevi e larghi. ║
M. volontari: sono costituiti da tessuto striato.
Di colore piuttosto intenso a causa della forte vascolarizzazione, si
contraggono velocemente e sono posti sotto il controllo della volontà.
Hanno forma allungata, a lamina o ad anello, e sono avvolti da una membrana
connettivale detta
endomisio, mentre l'insieme dei fasci muscolari
è a sua volta avvolto nel
perimisio; tale membrana si prolunga nei
tendini, porzione bianco-giallastra non elastica che serve all'inserzione
del
m. La parte contrattile, il
ventre, si presenta molle se
rilassata, dura e tesa in caso di contrazione. ║
M. involontari:
dipendono dal sistema nervoso vegetativo e sono formati da fibre muscolari
lisce. La loro contrazione, che deve garantire funzioni proprie della vita
vegetativa quali la digestione e la respirazione, avviene piuttosto lentamente.
Si tratta di
m. presenti generalmente nelle pareti dei visceri e dei
vasi, ed hanno forme varie. ● Fisiol. - I
m. si contraggono sotto
l'azione del sistema nervoso o per stimoli diretti. Alcuni di essi si
contraggono soprattutto in condizioni isotoniche (
m. che svolgono
movimenti di estensione o di flessione, dotati di fibre lunghe), altri in
condizioni isometriche (
m. che servono a mantenere la posizione eretta
del corpo, con fibre piuttosto brevi): spesso si riconoscono nella contrazione
di uno stesso
m. una fase isotonica e una isometrica. La risposta
contrattile, o scossa muscolare semplice, è dovuta ad un singolo stimolo
di breve durata; durante tale contrazione si distinguono tre fasi: di latenza
meccanica, di accorciamento e di rilasciamento. Nella contrazione, oltre ai
processi meccanici ad essa associati, si verificano manifestazioni elettriche
simili a quelle delle fibre nervose. In seguito ad una stimolazione, nelle fibre
muscolari striate si assiste ad un periodo di refrattarietà durante il
quale viene abolita (refrattarietà assoluta) o semplicemente diminuita
(refrattarietà relativa) la capacità del
m. di rispondere
ad altri stimoli. Tale stato transitorio può variare, quanto a durata, da
pochi millesimi di secondo a tutto il periodo della contrazione. Stimoli
ripetuti oltre una certa frequenza provocano uno stato di contrazione
persistente detto
tetano muscolare; se la frequenza non è tale da
determinare una fusione completa delle singole contrazioni si verifica il
tetano incompleto o
clono, che si manifesta come risposta
ondulatoria a scatti. L'impulso al movimento è dato nei
m.
scheletrici da fibre nervose di moto le quali, dividendosi in numerosi rami,
terminano nella
placca motrice (o giunzione neuromuscolare). Con
unità motoria si intende l'insieme delle fibre muscolari innervate
da una stessa fibra nervosa; esse vengono stimolate simultaneamente da uno
stesso impulso nervoso. In caso di distruzione dei nervi motori si verifica
atrofia del
m. I
m. striati prendono il nome dal tipo di movimento
che essi svolgono (flessori, estensori, adduttori, ecc.) oppure dal numero dei
capi d'inserzione (bicipite, tricipite, ecc.); tale nome può essere
seguito da quello dell'organo servito, oppure riferirsi semplicemente alla forma
(per esempio,
m. quadrato, trapezio, ecc.). Si definisce
m.
antagonista di un altro quello che causa un'azione opposta (ad esempio, sono
antagonisti il bicipite e il tricipite brachiale, rispettivamente flessore ed
estensore). I
m. scheletrici funzionano come leve, con uno o più
punti d'appoggio su segmenti ossei, e avvicinando o allontanando un altro
segmento osseo, su cui inseriscono l'altro capo, articolato con il primo. Nelle
leve muscolari il
fulcro è, in genere, l'articolazione fra due
segmenti ossei o fra un segmento osseo e un punto esterno; la
potenza
è la forza del
m. inserita nel suo punto di applicazione; con
resistenza opposta al lavoro del
m. si intende il peso da
sollevare, mentre con
braccio si definisce la distanza fra il fulcro e i
punti di applicazione della potenza e della resistenza. Tali leve possono essere
di I ordine (come nel caso dell'articolazione del capo sul collo), di II ordine
(per esempio, la flessione del piede sul suolo), di III ordine (la flessione
dell'avambraccio).
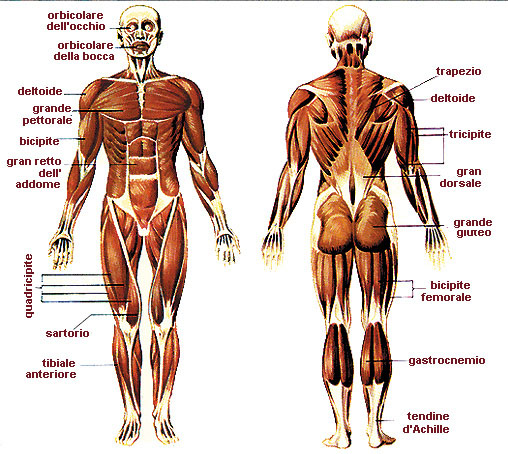
L'apparato muscolare